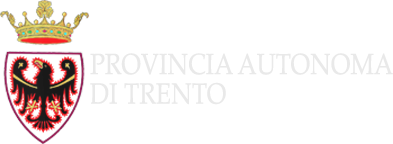La traduzione manoscritta o «sommersa» nella cultura europea (1700-1950)
Call for papers - Scadenza presentazione proposte 30 aprile 2021
Call for papers prorogata al 31 maggio 2021

Accademia Roveretana degli Agiati
8-9 novembre 202
Nella cultura europea moderna e contemporanea esiste una particolare tipologia di traduzione che si potrebbe chiamare sommersa, perché rimane celata, sotto forma di manoscritto o dattiloscritto, nell’archivio di un traduttore o di un editore. Le ragioni che spiegano la natura di questo particolare fenomeno di versione inedita sono molteplici: l’esplicito carattere di esercitazione letteraria o di trasposizione tecnica, il ripensamento o il mancato completamento da parte del suo artefice, l’accantonamento a causa di una versione più rapida ad essere stampata, le difficoltà o le incomprensioni insorte tra il traduttore, da una parte, e l’autore o l’editore, dall’altra, ecc.
La fallita pubblicazione di una traduzione non vuol dire però necessariamente la sua mancata circolazione.
Ci sono versioni che, pur essendo inedite, transitano ugualmente all’interno di reti di sociabilità intellettuale più o meno strutturate, assicurando una conoscenza precoce e ufficiosa del testo trasposto. Tale fenomeno può essere assimilato a quello che la moderna storiografia ha definito la comunicazione manoscritta, di cui la filosofia clandestina settecentesca costituisce senza dubbio la punta dell’iceberg.
La traduzione sommersa, anche se non può avere una diffusione paragonabile a quella a stampa, rappresenta tuttavia uno straordinario banco di prova per indagare tutte le pratiche o «tattiche» traduttologiche, di cui si avvale il traduttore letterario nel passaggio di un testo da una lingua all’altra e da un sistema culturale all’altro.
Essa permette di analizzare innanzitutto se la versione è stata realizzata direttamente sull’opera originale oppure su un metatesto, costituito dal montaggio o dalla collazione di edizioni diverse dello stesso testo.
Inoltre consente di verificare se vi sia stato l’eventuale impiego di parziali o integrali traduzioni indirette o relais, chiamate anche da Jürgen von Stackelberg «traduzioni di seconda mano» (Übersetzungen aus zweiter Hand). Il carattere autografo delle versioni sommerse permette ‒ molto di più rispetto a quelle a stampa, di cui si è perso il manoscritto o il dattiloscritto originario ‒ di svolgere delle mirate indagini genetiche per ricostruire il complesso lavoro del traduttore letterario, evidenziando, laddove se ne sono conservate le tracce, le sue eventuali opzioni sintattiche e lessicali, il bisogno di esplicitare, attraverso incisi paratestuali ad hoc, la difficile resa di una parola o di un sintagma nel passaggio da una lingua all’altra.
L’edizione postuma di una traduzione manoscritta non ne inficia in alcun modo lo statuto originario, dal momento che il suo destino ricade al di fuori dell’orizzonte d’intenti del suo artefice per essere piegato alle rivendicazioni di un altro attore che agisce ex post.
Lo studio delle versioni sommerse non offre solo la possibilità di far riemergere dall’oblio un nucleo di materiali letterari del tutto negletto sino ad oggi, ma di approfondire allo stesso tempo l’estensione reale delle pratiche di mediazione tra realtà culturali diverse, transitate non esclusivamente attraverso il canale editoriale.
In questa edizione del convegno saranno prese in considerazioni soltanto proposte relative a traduzioni manoscritte o dattiloscritte stilate tra il 1700 e il 1950 nelle principali lingue vive europee, quali italiano, francese, tedesco e inglese, a partire da opere in prosa o/e in versi pubblicate negli stessi idiomi.
Ogni singola proposta dovrà contenere:
- il titolo del contributo;
- il nome dell’autore e l’indicazione della sua appartenenza istituzionale;
- un breve riassunto dell’intervento (max 1000 caratteri, spazi inclusi);
- l’indicazione del manoscritto o del dattiloscritto oggetto della ricerca, precisando il luogo di conservazione e la natura del supporto (manoscritto autografo, manoscritto allografo, bella o brutta copia, bozza, ecc.);
- un breve curriculum del proponente (max 300 caratteri, spazi inclusi).
La proposta, stilata a discrezione dell’autore in italiano, francese, inglese o tedesco, dovrà essere inviata entro il 30 aprile 2021 al seguente indirizzo mail: traduzionemanoscritta@agiati.org.
A partire dal 1° luglio 2021 verrà data comunicazione agli interessati se la loro proposta è stata selezionata per il seminario.
Il comitato scientifico del convegno è formato da: Stefano Ferrari (Accademia Roveretana degli Agiati), Michele Sisto (Università degli Studi di Pescara-Chieti), Paola Maria Filippi (Università degli Studi Bologna) e Alessia Castagnino (Università degli Studi di Milano).
Per informazioni e bando in pdf www.agiati.org
23/03/2021