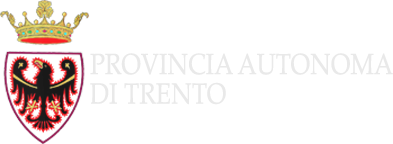"Voglio vedere il sangue. La violenza nel cinema contemporaneo" di Leonardo Gandini
Per il cinema contemporaneo la sfida consiste nell’affrontare il rapporto di complicità ed attrazione che la violenza
intrattiene, lontano dagli schermi e dalle sale, con le nozioni di sguardo, visione e spettacolo

“A dispetto delle sue inevitabili conseguenze sul piano fisico, la violenza è prima di tutto una categoria culturale. In quanto tale va soggetta a definizioni e classificazioni che variano di epoca in epoca e nei diversi contesti sociali (…) Nel corso degli ultimi secoli si è venuto progressivamente assottigliando il numero degli atti di violenza che una comunità è disposta a tollerare e giudicare compatibile alle proprie norme sociali. Un caso esemplare è rappresentato dalle esecuzioni in pubblico, forma gradita e diffusa di intrattenimento sino al diciottesimo secolo, la pena di morte ha gradualmente smesso, da quel momento in poi, di essere associata ad un evento spettacolare, per poi venire, in epoche a noi più vicine, segregata in luoghi appartati, al riparo dagli sguardi della collettività (…) Nel passaggio da una discussione della morte in diretta ad una che riguarda le sue forme di mediazione letteraria o visiva, nel dibattito si sono dunque infilati termini come "bellezza” e “fascino” che rimandano inequivocabilmente all'idea di una dimensione estetica della violenza”. da Voglio vedere il sangue. La violenza nel cinema contemporaneo (Mimesis, 2014) di Leonardo Gandini, professore di Storia e critica del cinema ed estetica del cinema presso l’Università di Modena e Reggio Emilia.
“La rimozione dell’esecuzione pubblica, il passaggio da un processo di spettacolarizzazione a uno di occultazione: non dimeno, la violenza mantiene il suo appeal. Tanto più smette di essere spettacolare dal vero, tanto più si moltiplica sul piano spettacolare, funzionale – spiega Gandini -. La nostra civiltà non ha mai smesso di provare un’attrazione colpevole per la violenza, e con il sesso funziona in modo analogo”.
Con un atteggiamento troppo approssimativo, “ci si illude di eliminare la violenza attraverso forme pedagogiche di pacificazione degli individui, un semplicismo basato sul disconoscimento del fatto che esiste una componente di violenza con cui tutti dobbiamo fare i conti – continua -. Nella loro estremità, sia i sostenitori del punto di vista aristotelico della violenza quale “catarsi”, sia chi pensa che essa abbia effetti devastanti, condividono un importante tratto comune: dallo spettacolo della violenza lo spettatore non esce indifferente. Come esce, pacificato o imbelvito?”
L’idea del contatto con qualcosa di pericoloso e perturbante sviluppa dei processi di moralizzazione.
“Di quale violenza stiamo parlando? – riprende il docente - Ci sono molti medium e ciascuno risponde in modo diverso: dai film ai videogiochi, dalle foto ai programmi televisivi alle graphic novel,ciascuna forma di mediazione ha le sue regole cui conseguono effetti diversi sullo spettatore. La violenza è un “test”, il regista come un pittore rinascimentale che si cimentava con un tema dell’iconografia classica, fa fronte alla sfida estetica di trovare una prospettiva di messa in scena originale”.
Il cinema, rispetto agli altri mezzi, ha dalla sua la possibilità di inserire la violenza in un contesto narrativo. “Per questo nel cinema la violenza non è mai gratuita – prosegue Gandini - nonostante gli attacchi siano paradossalmente proprio di questo tenore. In realtà, la violenza viene ricondotta all'interno di una trama che ci fa capire perché si arrivi allo scontro”.
Verso la fine degli anni sessanta qualcosa di diverso succede: “Si allentano le maglie della censura cinematografica per la concorrenza della televisione, un antagonismo analogo a quello che oggi viene da streaming, dal download – approfondisce -. La televisione è estremamente sorvegliata nei contenuti, allora l’industria hollywoodiana capisce che per rispondere alla concorrenza televisiva bisogna essere più espliciti, entrare in campi dove la tv non poteva entrare. Dalla “stenografia” si passa alla “calligrafia” della violenza, si comincia a vedere il sangue, morti elaborate, una crescita esponenziale nelle modalità di messa in scena. La violenza diventa una categoria estetica, un po' come succede nelle scene di sesso”.
Per spiegare questo processo, Gandini si sofferma sugli effetti prodotti dalla guerra del Vietnam, “ la prima che ha una copertura televisiva capillare quasi in diretta. Gli americani, per i quali la guerra era palestra di eroismo, che erano rimasti estranei alla Seconda guerra mondiale, vedono corpi di ragazzi americani in buste di plastica. Forse il movimento pacifista nascerà dall’improvvisa consapevolezza di cosa sia una guerra”.
Il punto cruciale riguarda la distinzione tra violenza “giusta” e non, cioè lo spazio ambiguo della violenza, in cui due questioni si mescolano.
“Una estetica e una etica – riprende Gandini - cioè tutte le volte che i registi si adoperano per dare raffinatezza estetica alla violenza – penso ai film di Sorrentino o ad Arancia meccanica - , vengono accusati di essere violenti. Si mette in gioco una componente edonistica che tracima dal set allo schermo, dallo schermo alla platea, finendo per contagiare lo spettatore. Non amiamo la violenza tout court, ma quella messa in scena con una certa sofisticatezza. Ma ciò non significa che quando usciamo dalla sala portiamo con noi la violenza”.
Attraverso il suo libro Gandini analizza gli snodi cruciali dell’argomento riportandoli a tre questioni: lo sguardo; la forma cioè in che modo si può mettere in scena la violenza nel cinema, e non solo; la morale.
17/03/2015