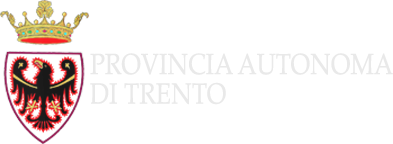Il gabbiano

IL GABBIANO
di Anton Čechov
traduzione Leonardo Manzan
regia Filippo Dini
con Giuliana De Sio, Filippo Dini e cast in definizione
scene Laura Benzi
costumi Alessio Rosati
luci Pasquale Mari
musiche Massimo Cordovani
produzione TSV - Teatro Nazionale, Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale, Teatro di Roma - Teatro Nazionale, Teatro Stabile di Bolzano, Teatro di Napoli – Teatro Nazionale
Note di regia di Filippo Dini
Mai si deve mentire. L’arte ha questo di particolarmente grande: non tollera la menzogna. Si può mentire in amore, in politica, in medicina; si può ingannare la gente, persino Dio; ma nell’arte non si può mentire…
Mi si rimprovera di scrivere solo di avvenimenti mediocri, di non avere eroi positivi; ma dove trovarli? Non chiederei di meglio! …
Tutti, sinchè siamo giovani, cinguettiamo come passeri sopra un mucchio di letame; a quarant’anni siamo già vecchi e cominciamo a pensare alla morte. Che specie di eroi siamo?…
Volevo solo dire alla gente in tutta onestà: guardate, guardate come vivete male, in che maniera noiosa. L’importante è che le persone comprendano questo; se lo comprenderanno, inventeranno sicuramente una vita diversa e migliore. L’uomo diventerà migliore quando gli avremo mostrato com’è.
- Anton Čechov - da una lettera ad Aleksej Suvorin
Un giorno, mentre cacciava con Čechov nel bosco, Levitan (pittore, suo amico) ferì una beccaccia e, non avendo il coraggio di finirla, chiese all’amico di farlo in vece sua. I grandi occhi neri dell’uccello guardavano stupefatti l’uomo che l’aveva appena abbattuta. Battendo le palpebre, il viso stravolto da una smorfia di colpevolezza, Levitan supplicò: «Fracassale la testa sul calcio del fucile!». Dapprima Čechov rifiutò; poi vinto dalle insistenze del pittore, uccise la beccaccia. Confessò a Suvorin: «Vi furono così nel mondo un’incantevole e tenera creatura in meno e due imbecilli che sono rientrati a casa e si sono seduti a tavola».
Pare che questo episodio, accaduto pochissimo tempo prima che il nostro autore iniziasse a scrivere Il gabbiano, lo abbia così impressionato da meritare una sua degna sublimazione nell’opera, proprio a metà del secondo atto, quando Kostja decide di uccidere vilmente un gabbiano, per portarlo come macabro omaggio alla sua innamorata.
La storia de Il gabbiano è molto nota: un gruppo di persone, di diverse età e collegate tra loro da vincoli di parentela e non, si riuniscono casualmente in una casa di campagna in riva a un lago e qui dibattono per tre atti, nel tentativo di fuggire al grigiore del loro destino. Fra le diverse storie che si intersecano nella piece, emerge con prepotenza, la vicenda di un giovane ragazzo che desidera risollevarsi da quel grigiore, attraverso l’arte della scrittura, sostenuto e infiammato dall’amore per una sua coetanea, che sogna di diventare un’attrice, e fomentato dal tentativo di opporsi con veemenza e passione alla madre, una famosa attrice, fidanzata con un importante scrittore assai più giovane di lei.
La commedia nei primi tre atti, si sviluppa attraverso una sorta di parabola discendente, che precipita nel gorgo dell’illusione. Parte nella gioia, nella passione, nell’eccitazione divertita e gioiosa del gioco, parte con il Teatro, nel primo atto Kostja mette in scena un testo che ha appena scritto, lo presenterà al mondo, e a recitarlo sarà la sua innamorata, che sogna di fare l’attrice. Come dice il maestro, innamorato di Masa: «Questa sera le loro anime nell’ansia di dar corpo a una stessa identica immagine, una di quelle immagini di cui vive l’arte, diventeranno un’anima sola». Non succederà, lo spettacolo finirà prima del previsto, perché sarà lo stesso autore/regista ad interromperlo, poiché infastidito dai commenti del pubblico, in particolare da quelli di sua madre. Tutto, da questo momento in poi, precipiterà abbastanza velocemente, fino a culminare nel punto più oscuro e terribile della vita di ognuno di noi, quell’istante in cui ciò che era desiderato e auspicabile, solo sognato e irraggiungibile, che si tratti di un amore o di un’ambizione professionale o artistica (Čechov sembra farli procedere sempre insieme), per la prima volta si delinea nella nostra mente e nel nostro cuore, come irrinunciabile e possibile, è il giorno in cui diciamo a noi stessi che non si potrà tornare indietro, è il giorno in cui i nostri sogni stanno per diventare il nostro domani. Qui Čechov chiude il terzo atto: Medvedenko sposerà Masa, Trigorin e l’Arkadina ripartiranno per Mosca, Kostja diventerà uno scrittore, Nina diventerà un’attrice, e inizierà una relazione con Trigorin.
Il quarto atto, che costituisce un racconto autonomo e indipendente, anche cronologicamente, poiché si svolge due anni dopo i precedenti, narra di come tutti i tentativi e le pulsioni di riscatto messe in atto da parte di tutti i personaggi, si siano scontrate contro il muro della quotidianità e abbiano modificato le vite di tutti, trasformandole in orribili esistenze colme di rimpianti, e su tutte, a simbolo di questo tragico fallimento, il giovane Kostja, dopo un ultimo confronto con la sua amata (quell’amore che fu generatore di tutto), decide di togliersi la vita. In realtà il dottore, dopo aver sentito lo sparo, andrà a controllare, verificherà che effettivamente il ragazzo si è ucciso, ma per non far preoccupare la madre dirà che il rumore è stato provocato dallo scoppio di una boccetta di etere (usato all’epoca come anestetico). Čechov sembra suggerirci un lieto fine: Konstantin è morto e rinato, ha mutato la sua forma, ha sublimato la propria condizione giunta al termine, l’ha spinta oltre i confini del tempo e della materia, passando dalla forma umana a quella gassosa, rinascendo come un essere vivente nuovo, più leggero, liberato per sempre dal peso dei suoi fallimenti.
Il nostro autore sembra voler precipitare, in maniera inesorabile e priva di speranza, ciascuno dei suoi personaggi, nell’impossibilità di realizzare un personale miglioramento nella vita o la consacrazione delle proprie ambizioni. L’intero dramma è una testimonianza dell’assurdità del destino umano. Sembra non esistere progetto grandioso che non sia votato, prima o poi, all’insuccesso; come dovesse occorrere un’energia sovrumana per gettare una passerella sull’abisso che separa il sogno dalla realtà.
O meglio, credo voglia indicarci in che modo, secondo quali principi e per quali cause, le migliori e più nobili pulsioni sono destinate a fallire.
La vicenda si svolge in un non luogo ai confini del mondo, popolato da un piccolo gruppo di esseri speciali per la loro impossibilità a convivere. Čechov sembra voler rappresentare una metafora di tutta l’umanità; come in un esperimento, mette insieme dieci esseri che, se inseriti nello stesso ambiente vitale, se fatti interagire, non potranno far altro che soccombere e fallire nei loro intenti.
Per rendere questo esperimento ancora più efficace, lo riempie d’amore e di sogno: il maestro Medvedenko ama Masa, ma lei ama Kostja, che a sua volta ama Nina; sia Nina che l’Arkadina (la madre di Kostja), amano Trigorin; Polina ama il dottor Dorn; Samraev (marito di Polina) odia tutti, Trigorin probabilmente non ama nessuno e il dottor Dorn forse ama l’umanità intera, ma comunque nessuno ricambia l’amore del suo/sua innamorato/a, non c’è nessun «amor, ch’a nullo amato amar perdona» in questa commedia, ogni amore è destinato a cadere nel nulla, nell’indifferenza, in alcuni casi nella disperazione.
Questa umanità in miniatura ci racconta di come possa accadere che le nostre migliori energie, i nostri più luminosi talenti, il nostro amore più appassionato, possano tutti essere stravolti e corrotti secondo le leggi del consorzio umano nel quale tentiamo di esprimerli. L’allegra comitiva de Il gabbiano, pur partendo con le migliori intenzioni, si dirige verso l’oblio, inesorabilmente. E ad osservarli c’è appunto un animale (che dà il titolo alla commedia) strano e contraddittorio, aggressivo e nobile nell’aspetto, elegante e volgare, un uccello attratto dalle acque del lago, che vola sulle loro teste, li osserva (come il pubblico che assiste allo spettacolo), ma ad un certo punto viene ucciso nella maniera più vile.
L’immortalità di questo testo e la sua bruciante contemporaneità sta proprio nella descrizione di una “umanità alla fine”, una società sull’orlo del baratro, che avverte l’arrivo di un’apocalisse, che di lì a poco spazzerà via tutto il mondo per come lo abbiamo conosciuto fino a quel momento, di lì a vent’anni, infatti, ci sarà la Rivoluzione, e anch’essa sarà causa o effetto (a seconda dei casi) di tante rivoluzioni in Europa. Tutta la drammaturgia di Čechov racconta una fine imminente, i suoi personaggi sono un popolo di ombre che tentano di resistere con tutte le loro forze alla malinconia, alla tristezza, al rammollimento cerebrale, lottano, si scontrano, si sparano, tra di loro e a se stessi, cercando di non soccombere. Le somiglianze con la nostra epoca sono straordinarie e sconfortanti, come se il nostro Anton ci guardasse da lontano con quel sorriso e quell’ironia che gli sono certamente congeniali, nell’attesa che anche la nostra società, il nostro mondo, il nostro folle modo di condurre le nostre esistenze, arrivi all’esplosione, proprio come la boccetta di etere del dottor Dorn.
Tutte le informazioni sul rinnovo o acquisto Abbonamento 25.26 cliccando qui
Per tutti gli aggiornamenti e/o eventuali modifiche al programma, consultare il sito ufficiale https://www.centrosantachiara.it/spettacoli/spettacolistagione/stagione-teatro-sociale-waikawa_gray