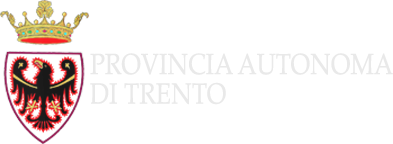Zea mays. Mais e pellagra nel Nord Italia tra fine Ottocento e inizio Novecento, La Vita Felice
presentazione del volume con interventi di: Valeria Carozzi, Andrea Leonardi, Cinzia Lorandini, Sandro Feller e Sergio Zaninelli.
"C’era una volta la pellagra…..". Sembra il classico incipit di ogni favola per bambini. Invece è il richiamo alla grande sventura che assieme alla emigrazione colpì le campagne della penisola tra Settecento e primi decenni del Novecento.
La pellagra era una malattia connessa, in un regime alimentare già di per sé poverissimo, al consumo prevalente, sotto forma di polenta o di pane, della farina di granoturco. E tuttavia la sua coltivazione ebbe per più secoli una grande e continua diffusione in ampie aree del Settentrione: era caldeggiata dagli agronomi per il ruolo che aveva nella rotazione delle colture, era apprezzata da proprietari e imprenditori per la convenienza di mercato, era accettata dai contadini come compenso per le loro prestazioni.
La malattia in sé e per le conseguenze che aveva – nella fase terminale la pazzia (spesso pellagrosari e manicomi erano contigui) - era indagata con i mezzi debolissimi delle conoscenze del tempo e contrastata con accorgimenti (come i forni per una corretta cottura del pane) del tutto inadeguati.
Scomparve quando, dopo il primo conflitto mondiale, l’alimentazione in quelle stesse zone ebbe un radicale cambiamento; a dimostrazione che nel consumo di mais posto alla base del nutrimento stava la causa determinante della pellagra, che non lasciò tracce dei suoi effetti devastanti.
La vicenda sembra dunque appartenere al passato da dimenticare, ma sarebbe un errore grave. Come è ben argomentato nel libro che verrà presentato il 27 novembre presso la Biblioteca civica, la pellagra ha una storia che rivela profonde connessioni con l’economia, la società e la politica del tempo.
Tutto questo emerge senza dubbi dalle pagine, dense di valutazioni e di notizie essenziali, di tre studiosi che la considerano dal punto di vista dell’antropologo, Lombroso, dello storico, Villari, del politico colto, Messedaglia. Il lettore vi troverà molti spunti di riflessione, ma soprattutto la risposta al quesito che bisogna porsi, anche e soprattutto nell’area trentina, che ha ben conosciuto la pellagra: perché parlarne al di là di una mera curiosità culturale? Perché su scala planetaria siamo di nuovo di fronte a squilibri tra abbondanza e scarsità (leggi fame), tra alimenti che giovano e alimenti che danneggiano la salute.
Il cibo si riconferma come il nesso vitale tra l’uso della terra e la nutrizione e quindi la vita dell’uomo. Ritornare alla pellagra offre spunti di riflessione quanto mai attuali e che non possiamo eludere.
organizzazione: Biblioteca civica in collaborazione con la Fondazione Ivo de Carneri Onlus